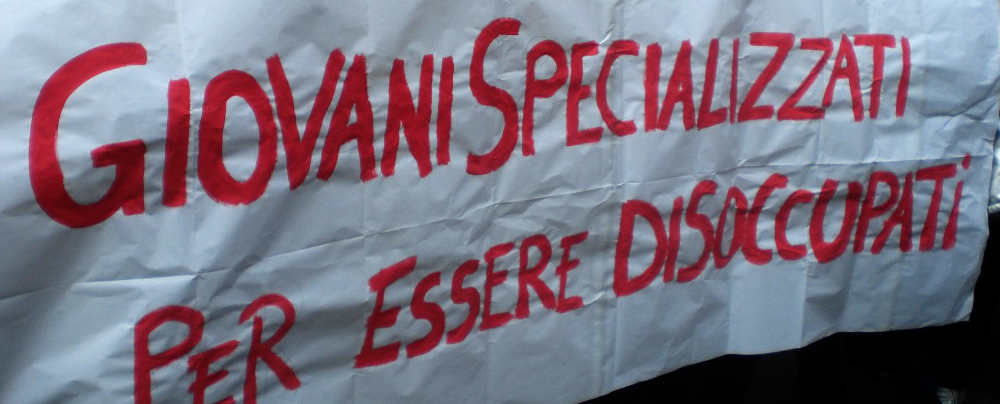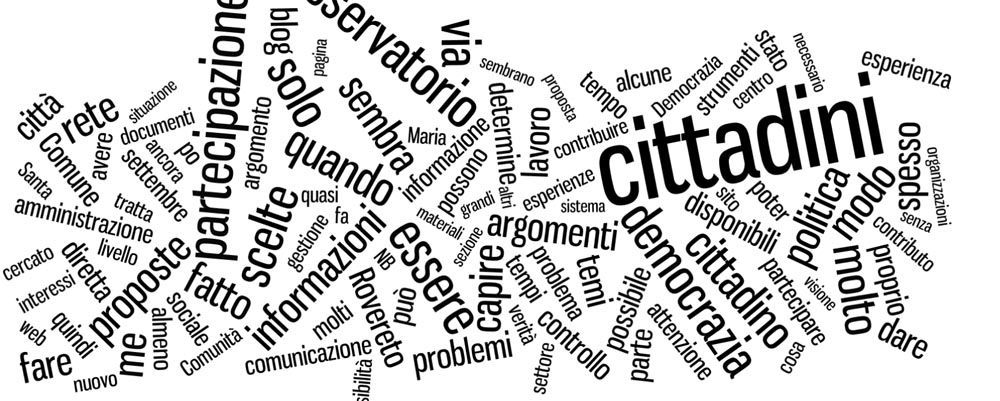Globalizzazione senza regole. Un’intervista a J. Stiglitz del 2006, ancora attuale.
Marco Contii, La repubblica 7 novembre 2006 Il dato di partenza è che la «globalizzazione, nelle sue forme e manifestazioni attuali, funziona molto male e produce un’enormità di