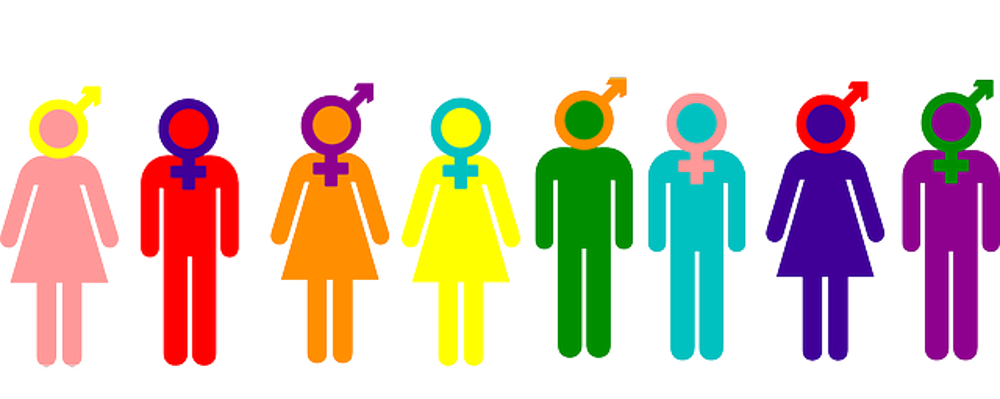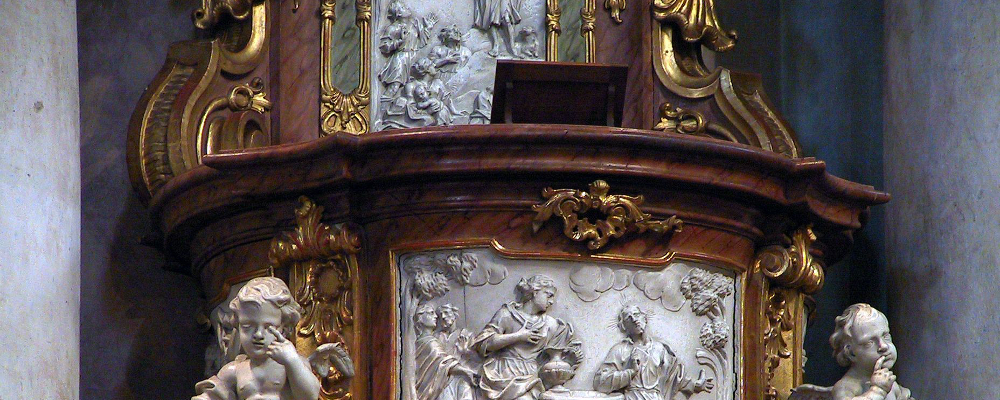Gender: ideologia e totalitarismo – Parola di Hannah Arendt
L’ideologia gender può entrare di diritto nei programmi curricolari delle scuole italiane, grazie a Renzi & Co. Chi nega questo, nega alla radice l’esistenza dell’ideologia gender, che sarebbe un’invenzione